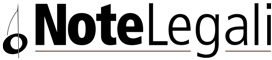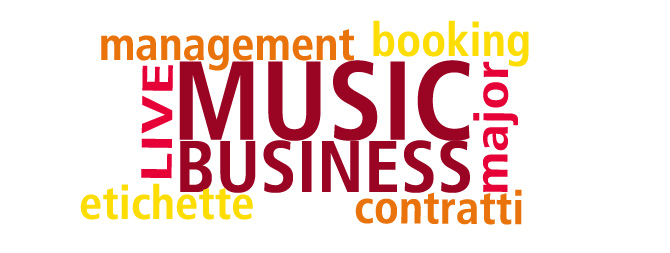Abbiamo già avuto modo nel numero di marzo 2014, di inquadrare correttamente il tema dell’adeguamento del compenso di copia privata per uso personale e di accennare alle numerose polemiche che tale questione, ciclicamente, solleva. Poiché a seguito dell’avvenuto adeguamento di tale compenso, nello scorso giugno, le polemiche non si sono placate, soprattutto da parte delle associazioni di consumatori, mi pare utile fornire ai gentili lettori un punto di vista “della categoria” a quanto, con molta disinformazione e malizia, si scrive e si dice in merito per attaccare un diritto acquisito (principio di legalità) e chi lo ha difeso nell’interesse di tutta la filiera (SIAE).
Innanzitutto è bene ricordare (e non ci si stanca mai di farlo) che:
1. Il compenso per copia privata per uso personale non è una “tassa” (soldi che vanno allo Stato), ma sono soldi che vanno nelle tasche del “settore musicale” (autori, editori, artisti, produttori);
2. Tale compenso esiste in Italia dal 1992 e poi è stato definitivamente disciplinato nel 2003 (D. Lgs 68/2003). Non è quindi una iniziativa dell’attuale governo;
3. Tale compenso esiste in tutta Europa (UK esclusa) e il sistema italiano è considerato in Europa in linea con le raccomandazioni formulate sulla copia privata. Non è quindi una invenzione nazionale, ma è figlio di una direttiva comunitaria (2001/29);
4. L’alternativa alla “eccezione” del diritto di copia privata per uso personale sarebbe vietare ai consumatori che abbiano acquisito legalmente un prodotto di farne copie per fruirne sulle proprie periferiche. Dovrebbero quindi comprare un “prodotto musicale” per ciascuna periferica nella quale vogliano copiare la musica acquistata, spendendo ben di più;
5. Il compenso non è un risarcimento per l’attività di pirateria “altruistica”, perché le copie di “prodotti musicali” non lecitamente acquisiti è sempre illegale e mai permessa;
6. Il sistema prevede un rimborso di tale compenso per i soggetti che non sono privati (ad esempio aziende che comprano pc, memorie di massa, ecc.) perché per essi non è possibile fare copie mancando l’uso personale. Si trovano tutte le informazioni sul sito di SIAE;
7. Tale compenso deve essere adeguato per decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ogni 3 anni sia nell’ammontare, sia rispetto alla definizione dei “supporti” oggetto di prelievo. L’adeguamento era atteso dal 2012 (quanto è cambiato il mercato da allora, non esistono neanche più le autoradio col lettore CD!). L’adeguamento è un atto dovuto e previsto per legge (art. 71-septies LDA) e non si può derogare. Si può certo discutere del quanto, ma non del se;
8. I compensi vengono raccolti da SIAE, che per comodità e indicazione di legge, funge da sportello di esazione, ma dedotto l’aggio che la SIAE utilizza per coprire tale lavoro (il 3%) non finiscono che per la metà agli autori ed editori (tramite SIAE stessa), mentre l’altra metà viene data agli artisti (tramite Nuovo IMAIE o altre collecting di artisti come ITSRIGHT e IPAA) e ai produttori fonografici (tramite SCF, PMI, AFI, AUDIOCOOP, ITSRIGHT, IPAA o direttamente da singoli produttori);
9. Non è vero che SIAE utilizza tali somme per coprire i propri “buchi di bilancio”, in primis perché SIAE non ne ha (potete trovare tutti i bilanci sul sito di SIAE), in secondo luogo perché l’unico incasso che ha SIAE è l’aggio, col quale copre (forse ampiamente, ma non ci è dato saperlo) le proprie spese di raccolta;
Ciò detto, per fare capire quanto il diritto d’autore sia per il “musicista” un diritto del lavoro, un diritto allo stipendio tale e quale a quello di altre categorie, mi piace riassumere la vicenda, non senza tono provocatorio, come segue: gli operai della FIAT chiedono il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto da due anni, e l’adeguamento del proprio stipendio a quello della media europea. Il fatto, con molto ritardo e tra molte polemiche, dopo avere sentito tutte le parti in causa infine, avviene, anche se lievemente sotto alle richieste dei lavoratori, ma comunque in modo soddisfacente. Di conseguenza FIAT, che si trova con un aumento di costi, potrebbe aumentare lievemente i prezzi delle proprie automobili (diciamo di 4 euro su 700 di normale prezzo di vendita), fatto che, inevitabilmente ricadrebbe sulle tasche dei consumatori.
L’analogia, con tutti i suoi evidenti limiti di natura, è di una semplicità imbarazzante. Un fatto normale. Su tale caso l’opinione pubblica sosterrebbe mai che lo stipendio degli operai sia una tassa, che ricade ingiustamente sulle tasche dei consumatori, che è iniqua, che l’aumento del prezzo serve solo a coprire i buchi di bilancio delle famiglie degli operai o addirittura dei sindacati (che hanno semplicemente condotto la trattativa), che se gli operai non dimostrano dove vanno a finire i soldi del loro aumento e come li spendono allora tale aumento è ingiustificato, che i sindacati sono da abolire completamente perché l’ennesima struttura mafiosa italiana, ecc.
A mio modesto parere quanto leggo dipinge un quadro grottesco, che la dice lunga di come manchi, sia in parlamento che tra i consumatori (ma anche tra i musicisti stessi assai timidi nel difendere i propri diritti) una qualunque informazione di base sul diritto della musica e sul music business. Laddove c’è disinformazione è molto più difficile fare valere i propri diritti!
Per una volta gli autori e gli artisti italiani hanno avuto quanto chiedevano: si accorgeranno nei prossimi anni di come questo episodio ha avuto effetti nelle proprie tasche. Noi, in un altro articolo, vi racconteremo come vengono ripartiti questi compensi e dove vanno a finire.
Questo articolo compare anche in Chitarre di settembre 2014