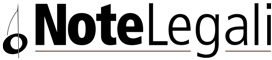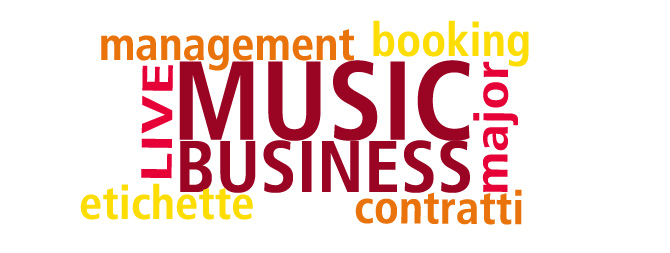Riprendiamo in questo appuntamento l’analisi delle varie modalità di prove di paternità di un’opera musicale che abbiamo inaugurato la in un altro articolo, alla ricerca di validi sistemi – alternativi al deposito della trascrizione dell’opera, riservato agli associati Siae – per difendere la propria qualifica di autore verso altri che potrebbero rivendicare lo stesso diritto contro di noi.
Posta elettronica
Un altro escamotage che può venire in mente potrebbe essere quello di sfruttare la posta elettronica, mandando a terzi o a sé stessi (in maniera analoga alla raccomandata di cui sopra) un file contenente l’opera da tutelare.
Dunque, vediamo i punti critici di questa strategia:
• la posta elettronica, nell’attuale legislazione italiana, ha valore legale sufficientemente sicuro solo come P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), cioè solo se risponde ai requisiti di legge (non basta di solito una semplice e-mail non certificata, sebbene ci siano alcuni giuristi che sostengono il contrario: al giudice l’ardua sentenza…); ricollegandoci al discorso sulle firme elettroniche, la posta non P.E.C. di per sé non dà sufficienti garanzie: sul mittente, sul destinatario, sull’orario di trasmissione, sui contenuti del messaggio.
Per avere garanzie, bisogna usufruire del servizio di P.E.C., fornito da soggetti autorizzati che certificano (con un sistema che ingloba ricevute digitali, firme digitali, marche temporali) l’avvenuta spedizione/ricezione del messaggio e i dati relativi all’operazione; In tale caso, il gestore della P.E.C. è obbligato a conservare un registro informatico (log) nel quale documenta l’operazione di invio/ricezione: tale log, ha si un valore probatorio, ma la tenuta del registro è obbligatoria solo per 30 mesi, dopo i quali, non si avrà più la sicurezza dell’avvenuto invio/ricezione;
• non mancano in ogni caso le voci critiche di giuristi sulla effettiva sicurezza del servizio P.E.C.;
• il servizio P.E.C., ancora una volta, si paga ed ancora una volta presenta la solita scadenza di legge degli effetti delle firme e marche digitali;
• la testimonianza di terzi citata inizialmente, potrebbe in definitiva crollare miseramente davanti al giudice, in mancanza dei requisiti di legge.
In definitiva, la posta elettronica non certificata non offre sufficienti garanzie probatorie, mentre la P.E.C. consentirà di avere una data certa perlomeno di invio del file, che ai fini probatori è quanto basta.
Pubblicazione dell’opera su Internet
Ingenuamente, alcuni ritengono che una prova valida sia la pubblicazione dell’opera in un sito Internet o in ogni caso la sua diffusione al pubblico mediante la Rete, magari attraverso la datazione che il motore di ricerca Google offre alle pagine inserite nella sua memoria cache. Ebbene, in caso di giudizio bisognerebbe provare sempre in maniera certa la data (cosa non facile in questo caso, secondo giuristi e giudici). Restano ampi margini di incertezza circa questa modalità, anche a causa della attuale mancanza di una legge italiana che disciplini organicamente il Web. Per chiarirci, una semplice stampa della videata della pagina del sito con l’opera da provare (dove ad es. si legge lo spartito) sarebbe insufficiente, se pensate:
• alla facile falsificabilità;
• all’incertezza della data, anche se riportata nella stampa.
Internet è un mezzo troppo ‘volatile’, quindi il numero di cautele necessarie per poter far valere in giudizio la pagina Web (ad es. con l’autenticazione di un notaio, con la marca temporale, ecc.) rischia di essere troppo gravoso rispetto agli altri sistemi.
Ugualmente il reperimento della pagina nella memoria cache di Google è un debole espediente: certo la cache indica una data di riferimento per l’archiviazione della copia e l’URL (cioè l’indirizzo del sito Internet) di richiamo della pagina, ma è vero anche che:
• non vengono rispettate le condizioni legali italiane di certezza e datazione temporale, con un ampia incertezza probatoria di fronte ad un giudice;
• spesso le pagine in cache possono essere cancellate da Google (nessun obbligo contrario in capo a Google);
• non sempre le pagine vengono memorizzate nel migliore dei modi, minando proprio la necessaria fedeltà all’originale;
• tutto il sistema può arrestarsi o essere cancellato (di nuovo, nessun obbligo contrario);
• è possibile una momentanea indisponibilità o un malfunzionamento, magari proprio nel momento cruciale per voi;
• non c’è nessuna garanzia sulla conformità della loro copia all’originale.
Deposito presso società straniere
È certamente possibile depositare l’opera presso società di gestione collettiva estere, come ad es. la GEMA tedesca, consorella della Siae, oppure presso il Copyright Office di Washington. Considerate attentamente però tutte le conseguenze:
• le associazioni straniere di gestione collettiva dei diritti d’autore analoghe alla Siae (come ad es. la GEMA tedesca, la SACEM. francese, ecc.), hanno proprie formalità, propri requisiti per la tutela e costi diversi da Paese a Paese, soggetti a mutamenti nel tempo (ad es. vi potrebbe essere vietato iscrivervi perché non aventi la cittadinanza o residenza in quel Paese); ostacolo non da poco potrebbe essere quello della lingua con cui relazionarsi; bisogna quindi valutare caso per caso se e come la società straniera offre un servizio di deposito delle opere con attribuzione di data certa, oltretutto valevole secondo i parametri probatori della legge italiana.
Precisiamo comunque che proprio la Siae offre un servizio di deposito delle opere presso il Copyright Office di Washington, aperto a tutti, pertanto è possibile ottenere tale effetto senza doversi relazionare direttamente con gli uffici americani: sarà la Siae a intermediare – a pagamento – per voi e a garantirvi un deposito efficace. Il deposito in parola prova: 1) internazionalmente, che che l’opera è registrata in un pubblico registro e per ottenere un certificato di deposito; 2) se il deposito è effettuato entro 5 anni dalla pubblicazione, la registrazione costituisce, nel corso d’una procedura giudiziaria negli Stati Uniti, prova incontestabile in tribunale della validità del copyright su quell’opera.
Deposito Opere Inedite in Siae
La Siae non offre solamente il «classico» deposito, riservato agli associati, mediante deposito online o trascrizione su spartito dell’opera e compilazione del bollettino 112, bensì anche il cd. il servizio di Deposito Opere Inedite, aperto anche ai non iscritti. Tale servizio è gestito dalla Sezione OLAF della Siae e fornisce una prova certa temporale. Il servizio può essere attivato anche da non iscritti alla Siae e consiste:
1) nella redazione di un modulo Siae (il mod. 350, reperibile sul sito SIAE), in cui indicare dati personali e delle opere da depositare;
2) nel deposito di una copia dell’opera (o di un insieme di opere), firmata in originale e per esteso con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi) da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo, anche fissata su di un supporto come CD, DVD, ecc. (in tal caso la firma e il titolo dell’opera vanno apposti al supporto, su di un’etichetta). Si badi che il supporto può contenere più opere in una volta, in qualunque formato, dunque il musicista potrebbe depositare un solo supporto CD contenente le tracce audio (o in digitale, come nel formato .mp3) di molti pezzi, senza alcun bisogno di trascrivere nulla;
3) nell’allegazione dell’attestazione di versamento della tariffa per il servizio.
Le tariffe per il deposito di un’opera inedita presso SIAE sono le seguenti (aggiornamento 2020):
– Euro 72,00 per gli associati e i mandanti;
– Euro 144,00 per i depositanti/autori non associati SIAE. (l’importo è comprensivo di imposta di bollo di € 2,00 versata in modo virtuale);
– Euro 288,00 per il deposito richiesto da persone giuridiche (società, associazioni, enti, consorzi, etc) che abbiano la disponibilità dei diritti di utilizzazione economica o da persone fisiche diverse dall’autore che da quest’ultimo abbiano acquisito i diritti di utilizzazione economica (l’importo è comprensivo dell’imposta di bollo di € 2,00 versata in modo virtuale).
La procedura è interamente gestita dalla Sezione OLAF, con sede a Roma, perciò l’insieme dei predetti materiali va consegnato o spedito direttamente a quella sede, il cui recapito potete trovare sempre sul sito della Siae. Il servizio consiste, quindi, nel ricevere il materiale, sigillarlo e custodirlo in un archivio, per 5 anni, al termine dei quali il richiedente potrà, versando di nuovo la tariffa detta prima, prorogare di altri 5 anni il deposito, oppure lasciare che la Siae distrugga il plico, venendo così meno tutti gli effetti probatori.
Qui il link alla sezione dei sito SIAE con tutte le informazioni: https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/deposito-opere-inedite.
Altre modalità
Per capire la difficoltà di provare la paternità dell’opera con altri metodi, giova descrivere brevemente che cosa dice la legge italiana riguardo alle prove che qui ci interessano.
Dovendo provare la data certa di creazione dell’opera, il Codice Civile italiano richiede che questa sia «opponibile ai terzi», cioè che sia collegata ad un fatto talmente sicuro, da stabilire con certezza che la prova è stata formata in una determinata data. Se si stabilisce come sicura questa data, la prova si avrà a partire da questo momento, non da una data anteriore di effettiva creazione dell’opera che anche se fosse vera non risulterebbe provata in alcun modo. Provato questo, se un’altra persona riuscirà invece a dimostrare, di fronte al giudice, che la sua opera (che deve essere identica o talmente simile alla vostra da non far dubitare che si tratti di plagio) risale ad un fatto precedente alla vostra prova, questa persona sarà riconosciuta autrice a vostro danno.
Dunque, oltre ai casi espressamente indicati dalla legge, tutti gli altri modi possibili di attribuire una data certa all’opera andranno valutati dal giudice. Come capire se il sistema probatorio che intendiamo adoperare potrà essere riconosciuto in tribunale? A parte i casi di legge, molto generici, un indice di assoluta certezza non c’è: ogni giudice può decidere in modo diverso, a seconda delle prove e del contesto, motivando diversamente. Qualcosa di abbastanza affidabile però, si può ricavare dalla lettura di passate sentenze in materia: il giudice non vi sarà vincolato, ma queste potranno avere una grossa influenza su di lui, soprattutto qualora siano state emanate da alti gradi di giudizio come la Corte di Cassazione. Ricordiamo, però, che le diversità tra un caso e l’altro possono portare a diverse soluzioni situazioni apparentemente simili.
Tra i vari altri modi adatti alla prova della paternità dell’opera possono elencarsi tutte le forme di pubblicazione che siano documentate con certezza relativamente alla data di resa pubblica, come giornali, quotidiani, riviste, televisione, radio. Anche un’occasione di esecuzione in pubblico dove si sia presentata l’opera, ad es. ad un concerto, una festa, un concorso, è idonea, ma andrà provata con una dignitosa registrazione avente in qualche modo data certa, oppure con più testimonianze affidabili, o ancora meglio entrambe le cose. In generale, la testimonianza è una forma di prova molto rischiosa, a causa della sua valutazione da parte del giudice. Ad es., il testimone deve preferibilmente essere un terzo “neutro” rispetto all’autore dell’opera, in quanto non deve avere un interesse nella causa. In materia civile è stato eliminato il divieto di testimoniare per coniugi, parenti e affini, quindi se questi non hanno, per il giudice, un interesse concreto ed attuale nella causa, possono testimoniare. Di solito il valore di una testimonianza viene aumentato da altre testimonianze concordi, come viene indebolito da altre che ne siano in contrasto. È evidente comunque che con la sola testimonianza, in genere, è altamente improbabile provare di essere autore di un’opera.
Chi sostiene che queste ipotesi abbiano valore legale (come anche alcune delle precedenti, specie informatiche) cerca, in sostanza, di accumulare prove di per sé non di gran valore, ma che sommate ad altre (di pari o anche inferiore valore) si spera possano convincere il giudice. Ebbene, il pericolo è elevato: il mancato rispetto dei requisiti di legge le rende poco o per niente utilizzabili. In generale, saranno da valutarsi caso per caso.
Un’ultima precisazione: quanto abbiamo detto vi aiuterà a capire come tutelare un’opera musicale, cioè la successione melodica di note che la compongono. Tuttavia la tutela della paternità del fonogramma, cioè della registrazione di una vostra esecuzione, fissazione in concreto dell’opera, si ottiene sfruttando, di nuovo, tutti i mezzi elencati sopra (in particolare vi consigliamo il Deposito Opere Inedite della Siae, a tal fine) se compatibili, nelle loro modalità, con il supporto o formato nel quale avete registrato la vostra musica.