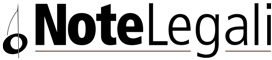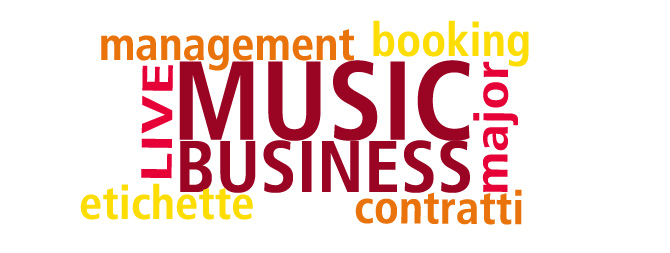Nell’ultimo appuntamento abbiamo passato in rassegna i codici ISWC e ISRC, d’uso per «marchiare» fonogrammi e opere musicali e consentire una miglior gestione e distribuzione degli stessi. Nondimeno nel mondo della musica non mancano altri numerosi codici e relativi risvolti applicativi.
Abbiamo citato nell’articolo precedente i codici CAE/IPI (ovvero codice Compositeur, Auteur, Editeur e codice Interested Party Information), anticipandone la funzione: vengono associati dalla CISAC ai soggetti aventi diritto, rientranti nella propria banca dati perchè coinvolti nella gestione collettiva dei diritti su opere musicali. In Italia la SIAE li associa automaticamente ai propri iscritti. Il CAE era il codice in vigore in passato, creato nel 1992 dalla SUISA (la SIAE svizzera) e impiegato dalla CISAC per identificare i compositori, autori ed editori, poi sostituito dall’ottobre 2001 dall’IPI che identifica un raggio più ampio di soggetti, opere e diritti (vedi anche su http://www.ipisystem.org). Viene rilasciato esclusivamente agli iscritti alle società di collecting affiliate CISAC e può essere adoperato per ritrovare altre opere facenti capo allo stesso soggetto, favorendo la gestione amministrativa, le ricerche di opere e dei loro aventi diritto. Il motore di ricerca universale dei codici IPI è l’ISWCNet database, liberamente consultabile (vedi il sito http://iswcnet.cisac.org/ISWCNET-MWI).
Il codice IPI identifica il ruolo del soggetto, che può essere di: editore, compositore (delle musiche), autore (del testo), arrangiatore (di musiche), adattatore (di testi), ecc. Un esempio di codice IPI può essere il seguente: I-000000229-7, di cui è evidente la suddivisione in prefisso del soggetto e numero di posizione.
Il codice ISMN (International Standard Music Number) è invece un codice alfanumerico identificativo di musica stampata in pentagramma, sviluppato dalla Commissione Tecnica ISO/TC 46 – Informazione e documentazione, sottocomitato SC9, ed è diventato uno standard nel 1993 (riconosciuto come «ISO 10957»).
La sua funzione identificativa aiuta la gestione di pubblicazione, diffusione, vendita e prestito di musica a stampa. Va da sé che i soggetti maggiormente interessati sono gli editori di musica a stampa, i rivenditori della stessa e i bibliotecari. L’ISMN permette di identificare la musica scritta (a stampa o in digitale) distintamente dalle altre pubblicazioni (abbinate di solito al codice ISBN – International Standard Book Number) nella catena distributiva globale, permettendo di realizzare, con maggior razionalità «globalizzata», repertori commerciali e servizi specializzati per il mercato delle edizioni musicali. Le edizioni musicali, in vendita o a noleggio, disponibili gratuitamente, in regime di Creative Commons o secondo le ordinarie forme tutelate dalla legge, sono l’oggetto di codificazione ISMN.
Il codice è composto da 13 cifre suddivise in quattro porzioni, come per esempio: 979-0-2306-7118-7, dove: a) 979-0 è il prefisso che distingue l’ISMN dagli altri codici standard; b) 2306 è il codice editore, il quale identifica uno specifico editore di edizioni musicali; c) 7118 è il codice prodotto che identifica una specifica pubblicazione di edizioni musicali; d) 7 è la cifra di controllo. Come tale, il codice può anche convertirsi in un formato grafico di codice a barre.
Il codice è assegnabile a diversi formati del pentagramma: si possono marcare partiture d’ogni tipo, altri media che siano parte integrante di una pubblicazione musicale (come per es. il CD con le registrazioni se abbinato all’edizione a stampa), testi di canzoni pubblicate con la musica a stampa (se disponibili separatamente), commenti critici pubblicati con la musica a stampa (se disponibili separatamente), musica stampata in Braille e persino pubblicazioni in formato elettronico (pensiamo per es. a un pentagramma in versione .pdf).
Non è invece attribuibile l’ISMN a libri che vertono sulla musica (si deve adoperare il citato codice a barre per l’editoria, l’ISBN), a registrazioni musicali o video non strettamente abbinati a un’edizione a stampa (per cui vale un codice a barre per beni di consumo, come l’EAN 13), a periodici e a libretti d’opera (sempre soggetti al codice ISBN).
In Italia l’agente esclusivo responsabile è Informazioni Editoriali I.E. S.p.a. di Milano, (contattabile via e-mail a info@ismn.it), mentre informazioni generali sono disponibili sul sito http://www.ismn.it. Chi è interessato ai codici ISMN deve inoltrare un modulo di richiesta prestampato all’agenzia italiana, così da ottenere i propri identificativi (in particolare quello di editore). Il servizio ISMN ha un costo, variabile a seconda del numero di partiture da editare, oscillante tra i 40 euro e i 1.500 euro per gruppo di codici.
L’agenzia invierà all’editore richiedente le schede bibliografiche, complete di codice ISMN precalcolato, che l’editore dovrà compilare e rispedire all’agenzia ogni volta che attribuirà un codice ISMN a una sua pubblicazione. A richiesta, pagando un costo supplementare, l’agenzia potrà rilasciare un annesso codice a barre EAN, i cui dettagli vedremo oltre.
L’editore, o altro soggetto richiedente il codice, stamperà il codice sull’opera al momento della stampa (ed eventuale ristampa) o comunque della pubblicazione, con un carattere leggibile e non inferiore a determinate dimensioni. È importante segnalare che sebbene il codice ISMN sia univoco per ogni opera, in caso di pubblicazione di parti separate della stessa si dovrà provvedere all’assegnazione di uno specifico codice cadauna.
Nell’era del digitale (una causa dello sviluppo dei codici qui illustrati) non possiamo mancare di riferire del DOI (Digital Object Identifier – Identificatore di Oggetto Digitale), sorta di codice a barre per la dimensione digitale (pensiamo a tutti i sistemi di reti ed il Web, in particolare per il commercio elettronico). Lanciato dalla Association of American Publishers e dalla Corporation for National Research Initiatives nel 1997, il DOI si propone come un permanente e affidabile sistema di identificazione di oggetti digitali, basato sulla tecnologia CNRI Handle System® e su di un database dei dati identificativi degli oggetti, tale da permetterne un efficace reperimento. Virtualmente il DOI è applicabile a ogni tipo di opera dell’ingegno – in qualsiasi formato – quindi anche ai fonogrammi e videogrammi musicali, indipendentemente dal supporto ove siano stati originariamente fissati.
Lo sviluppo tecnologico è compito del CINECA (consorzio di Università italiane) mentre la coordinazione europea è a cura dell’AIE (Associazione Editori Italiani): proprio così, una volta tanto è l’Italia a guidare l’Europa! In particolare dal punto di vista della gestione della mEDRA (Multilingual European DOI Registration Agency), l’agenzia europea di registrazione dei DOI, competente per i servizi forniti ai registranti (assegnazione, accesso, ecc.). Tutte queste strutture lavorano, tra l’altro, per garantire la cooperazione del DOI con altri sistemi informativi e così fornire una maggiore utilità ed efficienza. Ricordiamo che l’ente di governo internazionale è l’IDF (International DOI Foundation), organizzazione no-profit istituita nel 1998 e che salvaguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esso relativi.
Leggere un codice DOI non riserva, di per sé, grandi informazioni, essendo una semplice stringa (in formato ANSI/NISO Z39.84 – 2000) spartita in un prefisso («10.» seguito dal codice dell’organizzazione assegnante) e un suffisso (univoca stringa alfanumerica). Un esempio può essere questo: 10.1000/182.
La funzione del DOI è soprattutto quella di consentire a qualunque utente di raggiungere la collocazione dell’oggetto (soprattutto su Internet) e ottenere informazioni su di esso, visto che al contenuto vengono associati dei metadata di riferimento (bibliografico, commerciale, di collocazione nell’offerta editoriale), sempre aggiornabili. Sul Web è difatti possibile consultare la DOI Directory (vedi sul sito http://www.doi.org), mediante la quale è possibile, per autori, editori, distributori e utenti di contenuti digitali farsi conoscere, citare e ricercare, giovandosi all’uopo di un sistema persistente oltre che della gestione delle relazioni tra oggetti digitali e il deposito volontario di opere. Spieghiamoci meglio: identificando il contenuto dell’oggetto, invece dell’indirizzo URL nel Web dello stesso, il DOI consente di reperire risorse anche quando la pagina di collocazione sia mutata. Non solo: il DOI può costituire la prova che in una data precisa sia stata pubblicata una determinata opera. Con quale forza legale, è tutto da vedere a seconda del sistema legale del Paese ove si vuole ottenere la prova. Ad esempio, nel nostro Paese tale effetto è tutto da valutarsi e non è detto che possa essere di grande rilievo, essendo rimesso alla valutazione caso per caso del giudice. In futuro però un intervento legislativo, di taglio comunitario e poi nazionale, potrebbe rendere il valore legale del DOI assolutamente alla pari con altri già accreditati di pieno effetto, come la firma digitale, posto che viene rispettato il requisito della terzietà del certificatore. Le prospettive sono interessanti, vedremo.
Tutti conosciamo i classici codici a barre che quotidianamente ritroviamo su vari beni di consumo (nella classica forma di numeri e corrispondenti barrette verticali a contrasto), però anche questo tipo di codificazione conosce differenti standard, non da ultimo territoriali. La storia dei codici a barre comincia nel dopoguerra e trova solo negli anni ‘70, dapprima negli USA, lo sviluppo odierno. Nella musica il codice a barre è indicato per la stampa di supporti (fonogrammi o videogrammi, ove identificano l’intero prodotto e non le singole tracce) destinati alla commercializzazione, così da permettere ai distributori e rivenditori una razionale gestione dei flussi di magazzino e movimento merci, molto più rapidi grazie all’impiego dei lettori elettronici di codici a barre. Analogamente a codici già illustrati in precedenza, i codici a barre si dimostrano affidabili specialmente grazie alla cifra di controllo impiegata (cd. check digit) a fine codice.
Si noti che attualmente, in virtù di accordi internazionali tra varie agenzie come l’ISMN e l’ISBN, un editore che voglia apporre un codice a barre sui propri prodotti editoriali (e solo su questi, come ad es. un libro o uno spartito musicale) non è più obbligato a iscriversi a Indicod-Ecr per ottenere il codice a barre, bensì può fruire dei codici a barre in formato GTIN-13 forniti dalle altre agenzie, come appunto l’ISMN. Un esempio: il codice GTIN-13 per la musica a stampa è composto dal prefisso «979» seguito dal numero ISMN. Chiariamo che il GTIN-13 è solo una struttura numerica impiegata nei codici, non una tipologia di codice. È giunto ora il momento di introdurre i veri e propri codici a barre.
Parlando di codici a barre, la confusione di solito regna sovrana, vista la ricchezza di formati vecchi e nuovi ancora in vigore. Per fornire un primo orientamento possiamo dire che i due formati internazionali di base sono l’EAN e l’UPC, i quali però dal 2010 verranno affiancati a tutti gli effetti (specie sul fronte della compatibilità di lettura) da quello che dovrebbe essere il nuovo formato internazionale (già in uso), ovvero il GS1, che però non sostituirà del tutto i precedenti. Vediamone i dettagli per singoli codici, partendo dall’ultimo citato.
In Italia l’operatore della musica che desideri farsi rilasciare un codice a barre per un prodotto può richiederlo, nel formato GS1, all’Indicod-Ecr, l’istituto per le imprese di beni di consumo (vedi il sito http://www.indicod-ecr.it). Il rilascio è subordinato all’adesione ad Indicod-Ecr da parte dell’azienda produttrice/distributrice/importatrice del prodotto, azienda come tale responsabile di fronte ai consumatori nella veste del marchio apposto sulle confezioni. Cosa viene rilasciato esattamente? Viene attribuito un codice impresa di nove cifre, necessario prefisso per il codice completo (cui va aggiunto il prefisso territoriale italiano: «80-83»). Sarà poi il richiedente a generare da sé i relativi codici per prodotto (di tre cifre più una di controllo), mediante numerazione progressiva, tenuto conto che si potranno assegnare 1.000 codici articolo (da 000 a 999) e non di più, salvo l’assegnazione di un nuovo codice impresa. Si badi bene che il codice a barre identifica univocamente e universalmente un prodotto e il suo produttore, ma non contiene altri meta-data o informazioni, tranne casi particolari non applicabili al settore musicale.
L’iscrizione all’Indicod-Ecr avviene mediante compilazione di un form online, allegando la ricevuta di pagamento di una quota di iscrizione iniziale e di una fissa annuale. La quota di iscrizione varia a seconda di alcuni parametri, come il fatturato del richiedente. Iscriversi a Indicod-Ecr vuol dire far parte di un’associazione non a scopo di lucro, di cui si deve aver letto, compreso e condiviso lo Statuto.
Citiamo en passant che un «concorrente» internazionale del GS1 è il codice EPC (Electronic Product Code™), sorta di etichetta elettronica gestita internazionalmente dall’EPC Global (Indicod-Ecr in Italia). Le informazioni sul prodotto associabili e ricavabili da questo codice sono innumerevoli: qualsiasi caratteristica, il produttore e il prezzo sono alla base del codice. Le strutture numeriche utilizzate sono quelle tipiche del GS1 (come il citato GTIN) tuttavia il sistema di numerazione è estremamente versatile e potente, a 96 bit, e fornisce un unico numero identificativo a 268 milioni di aziende, ognuna delle quali avrà a disposizione 16 milioni di categorie e 68 miliardi di numeri seriali per ciascuna categoria di prodotto. Al codice in parola corrisponde l’EPCglobal Network, ovvero il database comune e a libero accesso, sviluppato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), sfrutta le componenti hardware e software per collegare i singoli server/database dei sottoscrittori/utenti, per garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle merci movimentate lungo la catena commerciale. Si evince, da quanto detto, che i vantaggi di questo standard, ancora in fase iniziale, sono innumerevoli e di certo lo sono l’incomparabile mole di informazioni codificata, la funzione anticontraffazione, la capacità di rilevamento attraverso sistemi a radio frequenza, la facilità di reperimento tramite Internet. Naturalmente una tale complessità richiede l’apposizione in un microchip, non bastando il canonico numero con rappresentazione grafica. Le prospettive dell’EPC sono molte alte, mirando ad una «connettività universale» tra tutti gli oggetti del mondo fisico.
Tornando ai codici oggi standardizzati, una particolarità riguarda il mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada): lì infatti il formato del codice a barre è il cd. UPC (Universal Product Code), composto da solo 12 cifre, diversamente da quello europeo di 13. Sebbene teoricamente dal gennaio 2005 i rivenditori americani abbiano assunto l’impegno di far riconoscere i codici europei a 13 cifre ai propri scanner e apparecchi di lettura, di fatto Indicod-Ecr consiglia di esportare negli USA utilizzando ancora i codici UPC. I codici UPC sono richiedibili sempre tramite l’Indicod-Ecr.
In Europa è invece adottato il sistema EAN 13 (European Article Number), il che comporta che ad ogni prodotto venga attribuito: a) un codice di identificazione numerico composto da 13 cifre; b) una corrispondente rappresentazione grafica, ovvero un simbolo a barre verticali, destinato alla lettura ottica. L’identificativo della nazione è il primo numero indicato. Fanno eccezione, per le particolarità del mercato mondiale, il settore dei periodici, dei libri e della musica a stampa i cui codici EAN iniziano rispettivamente con 977, 978 e 979 in tutto il mondo.
Ormai desueto, di fronte a tante innovazioni, è il cd. LC (Label Code), codice rilasciato dal 1977 dalla già menzionata IFPI a ogni etichetta fonografica richiedente, cui veniva attribuito un numero progressivo (prima di quattro poi di cinque cifre) identificativo delle proprie produzioni (ad es. «LC 0542» designa la EMI Records) così da poter più facilmente distinguere il produttore avente diritto.
Per concludere questa carrellata, puramente illustrativa, segnaliamo che di recente sono stati introdotti due codici di interesse del settore musicale, sviluppati dalla DDEX (Digital Data Exchange) nell’ambito del progetto MI3P (Music Industry Integrated Identifiers Project).
Il primo è il codice MWLI (Musical Works Licence Identifier), dalle ampie prospettive, visto che consente di monitorare lo stato dei diritti d’autore in licenza, opera per opera. L’utente potrà conoscere, grazie al MWLI, se l’opera è o meno in regime di licenza, a chi è assegnata, per quanto tempo, ecc. Tuttavia lo sviluppo e la diffusione di questa codifica sono ancora agli albori, dovendo per forza di cose essere armonizzato e coordinato con molti dei codici visti in precedenza, come l’ISWC e l’ISRC. La gestione spetta alla IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), ovvero dall’associazione internazionale dei produttori fonografici.
Altro risultato delle ricerche MI3P è il GRid (Global Release Identifier), gestito dalla CISAC. Questo sistema risponde all’esigenza di monitorare, nell’ambito del commercio elettronica, le pubblicazioni di fonogrammi, videogrammi e altre risorse in formato digitale. L’obiettivo è quello di integrare i sistemi visti in precedenza, come l’ISRC.Nell’ultimo appuntamento abbiamo passato in rassegna i codici ISWC e ISRC, d’uso per «marchiare» fonogrammi e opere musicali e consentire una miglior gestione e distribuzione degli stessi. Nondimeno nel mondo della musica non mancano altri numerosi codici e relativi risvolti applicativi.
Abbiamo citato nell’articolo precedente i codici CAE/IPI (ovvero codice Compositeur, Auteur, Editeur e codice Interested Party Information), anticipandone la funzione: vengono associati dalla CISAC ai soggetti aventi diritto, rientranti nella propria banca dati perchè coinvolti nella gestione collettiva dei diritti su opere musicali. In Italia la SIAE li associa automaticamente ai propri iscritti. Il CAE era il codice in vigore in passato, creato nel 1992 dalla SUISA (la SIAE svizzera) e impiegato dalla CISAC per identificare i compositori, autori ed editori, poi sostituito dall’ottobre 2001 dall’IPI che identifica un raggio più ampio di soggetti, opere e diritti (vedi anche su http://www.ipisystem.org). Viene rilasciato esclusivamente agli iscritti alle società di collecting affiliate CISAC e può essere adoperato per ritrovare altre opere facenti capo allo stesso soggetto, favorendo la gestione amministrativa, le ricerche di opere e dei loro aventi diritto. Il motore di ricerca universale dei codici IPI è l’ISWCNet database, liberamente consultabile (vedi il sito http://iswcnet.cisac.org/ISWCNET-MWI).
Il codice IPI identifica il ruolo del soggetto, che può essere di: editore, compositore (delle musiche), autore (del testo), arrangiatore (di musiche), adattatore (di testi), ecc. Un esempio di codice IPI può essere il seguente: I-000000229-7, di cui è evidente la suddivisione in prefisso del soggetto e numero di posizione.
Il codice ISMN (International Standard Music Number) è invece un codice alfanumerico identificativo di musica stampata in pentagramma, sviluppato dalla Commissione Tecnica ISO/TC 46 – Informazione e documentazione, sottocomitato SC9, ed è diventato uno standard nel 1993 (riconosciuto come «ISO 10957»).
La sua funzione identificativa aiuta la gestione di pubblicazione, diffusione, vendita e prestito di musica a stampa. Va da sé che i soggetti maggiormente interessati sono gli editori di musica a stampa, i rivenditori della stessa e i bibliotecari. L’ISMN permette di identificare la musica scritta (a stampa o in digitale) distintamente dalle altre pubblicazioni (abbinate di solito al codice ISBN – International Standard Book Number) nella catena distributiva globale, permettendo di realizzare, con maggior razionalità «globalizzata», repertori commerciali e servizi specializzati per il mercato delle edizioni musicali. Le edizioni musicali, in vendita o a noleggio, disponibili gratuitamente, in regime di Creative Commons o secondo le ordinarie forme tutelate dalla legge, sono l’oggetto di codificazione ISMN.
Il codice è composto da 13 cifre suddivise in quattro porzioni, come per esempio: 979-0-2306-7118-7, dove: a) 979-0 è il prefisso che distingue l’ISMN dagli altri codici standard; b) 2306 è il codice editore, il quale identifica uno specifico editore di edizioni musicali; c) 7118 è il codice prodotto che identifica una specifica pubblicazione di edizioni musicali; d) 7 è la cifra di controllo. Come tale, il codice può anche convertirsi in un formato grafico di codice a barre.
Il codice è assegnabile a diversi formati del pentagramma: si possono marcare partiture d’ogni tipo, altri media che siano parte integrante di una pubblicazione musicale (come per es. il CD con le registrazioni se abbinato all’edizione a stampa), testi di canzoni pubblicate con la musica a stampa (se disponibili separatamente), commenti critici pubblicati con la musica a stampa (se disponibili separatamente), musica stampata in Braille e persino pubblicazioni in formato elettronico (pensiamo per es. a un pentagramma in versione .pdf).
Non è invece attribuibile l’ISMN a libri che vertono sulla musica (si deve adoperare il citato codice a barre per l’editoria, l’ISBN), a registrazioni musicali o video non strettamente abbinati a un’edizione a stampa (per cui vale un codice a barre per beni di consumo, come l’EAN 13), a periodici e a libretti d’opera (sempre soggetti al codice ISBN).
In Italia l’agente esclusivo responsabile è Informazioni Editoriali I.E. S.p.a. di Milano, (contattabile via e-mail a info@ismn.it), mentre informazioni generali sono disponibili sul sito http://www.ismn.it. Chi è interessato ai codici ISMN deve inoltrare un modulo di richiesta prestampato all’agenzia italiana, così da ottenere i propri identificativi (in particolare quello di editore). Il servizio ISMN ha un costo, variabile a seconda del numero di partiture da editare, oscillante tra i 40 euro e i 1.500 euro per gruppo di codici.
L’agenzia invierà all’editore richiedente le schede bibliografiche, complete di codice ISMN precalcolato, che l’editore dovrà compilare e rispedire all’agenzia ogni volta che attribuirà un codice ISMN a una sua pubblicazione. A richiesta, pagando un costo supplementare, l’agenzia potrà rilasciare un annesso codice a barre EAN, i cui dettagli vedremo oltre.
L’editore, o altro soggetto richiedente il codice, stamperà il codice sull’opera al momento della stampa (ed eventuale ristampa) o comunque della pubblicazione, con un carattere leggibile e non inferiore a determinate dimensioni. È importante segnalare che sebbene il codice ISMN sia univoco per ogni opera, in caso di pubblicazione di parti separate della stessa si dovrà provvedere all’assegnazione di uno specifico codice cadauna.
Nell’era del digitale (una causa dello sviluppo dei codici qui illustrati) non possiamo mancare di riferire del DOI (Digital Object Identifier – Identificatore di Oggetto Digitale), sorta di codice a barre per la dimensione digitale (pensiamo a tutti i sistemi di reti ed il Web, in particolare per il commercio elettronico). Lanciato dalla Association of American Publishers e dalla Corporation for National Research Initiatives nel 1997, il DOI si propone come un permanente e affidabile sistema di identificazione di oggetti digitali, basato sulla tecnologia CNRI Handle System® e su di un database dei dati identificativi degli oggetti, tale da permetterne un efficace reperimento. Virtualmente il DOI è applicabile a ogni tipo di opera dell’ingegno – in qualsiasi formato – quindi anche ai fonogrammi e videogrammi musicali, indipendentemente dal supporto ove siano stati originariamente fissati.
Lo sviluppo tecnologico è compito del CINECA (consorzio di Università italiane) mentre la coordinazione europea è a cura dell’AIE (Associazione Editori Italiani): proprio così, una volta tanto è l’Italia a guidare l’Europa! In particolare dal punto di vista della gestione della mEDRA (Multilingual European DOI Registration Agency), l’agenzia europea di registrazione dei DOI, competente per i servizi forniti ai registranti (assegnazione, accesso, ecc.). Tutte queste strutture lavorano, tra l’altro, per garantire la cooperazione del DOI con altri sistemi informativi e così fornire una maggiore utilità ed efficienza. Ricordiamo che l’ente di governo internazionale è l’IDF (International DOI Foundation), organizzazione no-profit istituita nel 1998 e che salvaguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esso relativi.
Leggere un codice DOI non riserva, di per sé, grandi informazioni, essendo una semplice stringa (in formato ANSI/NISO Z39.84 – 2000) spartita in un prefisso («10.» seguito dal codice dell’organizzazione assegnante) e un suffisso (univoca stringa alfanumerica). Un esempio può essere questo: 10.1000/182.
La funzione del DOI è soprattutto quella di consentire a qualunque utente di raggiungere la collocazione dell’oggetto (soprattutto su Internet) e ottenere informazioni su di esso, visto che al contenuto vengono associati dei metadata di riferimento (bibliografico, commerciale, di collocazione nell’offerta editoriale), sempre aggiornabili. Sul Web è difatti possibile consultare la DOI Directory (vedi sul sito http://www.doi.org), mediante la quale è possibile, per autori, editori, distributori e utenti di contenuti digitali farsi conoscere, citare e ricercare, giovandosi all’uopo di un sistema persistente oltre che della gestione delle relazioni tra oggetti digitali e il deposito volontario di opere. Spieghiamoci meglio: identificando il contenuto dell’oggetto, invece dell’indirizzo URL nel Web dello stesso, il DOI consente di reperire risorse anche quando la pagina di collocazione sia mutata. Non solo: il DOI può costituire la prova che in una data precisa sia stata pubblicata una determinata opera. Con quale forza legale, è tutto da vedere a seconda del sistema legale del Paese ove si vuole ottenere la prova. Ad esempio, nel nostro Paese tale effetto è tutto da valutarsi e non è detto che possa essere di grande rilievo, essendo rimesso alla valutazione caso per caso del giudice. In futuro però un intervento legislativo, di taglio comunitario e poi nazionale, potrebbe rendere il valore legale del DOI assolutamente alla pari con altri già accreditati di pieno effetto, come la firma digitale, posto che viene rispettato il requisito della terzietà del certificatore. Le prospettive sono interessanti, vedremo.
Tutti conosciamo i classici codici a barre che quotidianamente ritroviamo su vari beni di consumo (nella classica forma di numeri e corrispondenti barrette verticali a contrasto), però anche questo tipo di codificazione conosce differenti standard, non da ultimo territoriali. La storia dei codici a barre comincia nel dopoguerra e trova solo negli anni ‘70, dapprima negli USA, lo sviluppo odierno. Nella musica il codice a barre è indicato per la stampa di supporti (fonogrammi o videogrammi, ove identificano l’intero prodotto e non le singole tracce) destinati alla commercializzazione, così da permettere ai distributori e rivenditori una razionale gestione dei flussi di magazzino e movimento merci, molto più rapidi grazie all’impiego dei lettori elettronici di codici a barre. Analogamente a codici già illustrati in precedenza, i codici a barre si dimostrano affidabili specialmente grazie alla cifra di controllo impiegata (cd. check digit) a fine codice.
Si noti che attualmente, in virtù di accordi internazionali tra varie agenzie come l’ISMN e l’ISBN, un editore che voglia apporre un codice a barre sui propri prodotti editoriali (e solo su questi, come ad es. un libro o uno spartito musicale) non è più obbligato a iscriversi a Indicod-Ecr per ottenere il codice a barre, bensì può fruire dei codici a barre in formato GTIN-13 forniti dalle altre agenzie, come appunto l’ISMN. Un esempio: il codice GTIN-13 per la musica a stampa è composto dal prefisso «979» seguito dal numero ISMN. Chiariamo che il GTIN-13 è solo una struttura numerica impiegata nei codici, non una tipologia di codice. È giunto ora il momento di introdurre i veri e propri codici a barre.
Parlando di codici a barre, la confusione di solito regna sovrana, vista la ricchezza di formati vecchi e nuovi ancora in vigore. Per fornire un primo orientamento possiamo dire che i due formati internazionali di base sono l’EAN e l’UPC, i quali però dal 2010 verranno affiancati a tutti gli effetti (specie sul fronte della compatibilità di lettura) da quello che dovrebbe essere il nuovo formato internazionale (già in uso), ovvero il GS1, che però non sostituirà del tutto i precedenti. Vediamone i dettagli per singoli codici, partendo dall’ultimo citato.
In Italia l’operatore della musica che desideri farsi rilasciare un codice a barre per un prodotto può richiederlo, nel formato GS1, all’Indicod-Ecr, l’istituto per le imprese di beni di consumo (vedi il sito http://www.indicod-ecr.it). Il rilascio è subordinato all’adesione ad Indicod-Ecr da parte dell’azienda produttrice/distributrice/importatrice del prodotto, azienda come tale responsabile di fronte ai consumatori nella veste del marchio apposto sulle confezioni. Cosa viene rilasciato esattamente? Viene attribuito un codice impresa di nove cifre, necessario prefisso per il codice completo (cui va aggiunto il prefisso territoriale italiano: «80-83»). Sarà poi il richiedente a generare da sé i relativi codici per prodotto (di tre cifre più una di controllo), mediante numerazione progressiva, tenuto conto che si potranno assegnare 1.000 codici articolo (da 000 a 999) e non di più, salvo l’assegnazione di un nuovo codice impresa. Si badi bene che il codice a barre identifica univocamente e universalmente un prodotto e il suo produttore, ma non contiene altri meta-data o informazioni, tranne casi particolari non applicabili al settore musicale.
L’iscrizione all’Indicod-Ecr avviene mediante compilazione di un form online, allegando la ricevuta di pagamento di una quota di iscrizione iniziale e di una fissa annuale. La quota di iscrizione varia a seconda di alcuni parametri, come il fatturato del richiedente. Iscriversi a Indicod-Ecr vuol dire far parte di un’associazione non a scopo di lucro, di cui si deve aver letto, compreso e condiviso lo Statuto.
Citiamo en passant che un «concorrente» internazionale del GS1 è il codice EPC (Electronic Product Code™), sorta di etichetta elettronica gestita internazionalmente dall’EPC Global (Indicod-Ecr in Italia). Le informazioni sul prodotto associabili e ricavabili da questo codice sono innumerevoli: qualsiasi caratteristica, il produttore e il prezzo sono alla base del codice. Le strutture numeriche utilizzate sono quelle tipiche del GS1 (come il citato GTIN) tuttavia il sistema di numerazione è estremamente versatile e potente, a 96 bit, e fornisce un unico numero identificativo a 268 milioni di aziende, ognuna delle quali avrà a disposizione 16 milioni di categorie e 68 miliardi di numeri seriali per ciascuna categoria di prodotto. Al codice in parola corrisponde l’EPCglobal Network, ovvero il database comune e a libero accesso, sviluppato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), sfrutta le componenti hardware e software per collegare i singoli server/database dei sottoscrittori/utenti, per garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle merci movimentate lungo la catena commerciale. Si evince, da quanto detto, che i vantaggi di questo standard, ancora in fase iniziale, sono innumerevoli e di certo lo sono l’incomparabile mole di informazioni codificata, la funzione anticontraffazione, la capacità di rilevamento attraverso sistemi a radio frequenza, la facilità di reperimento tramite Internet. Naturalmente una tale complessità richiede l’apposizione in un microchip, non bastando il canonico numero con rappresentazione grafica. Le prospettive dell’EPC sono molte alte, mirando ad una «connettività universale» tra tutti gli oggetti del mondo fisico.
Tornando ai codici oggi standardizzati, una particolarità riguarda il mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada): lì infatti il formato del codice a barre è il cd. UPC (Universal Product Code), composto da solo 12 cifre, diversamente da quello europeo di 13. Sebbene teoricamente dal gennaio 2005 i rivenditori americani abbiano assunto l’impegno di far riconoscere i codici europei a 13 cifre ai propri scanner e apparecchi di lettura, di fatto Indicod-Ecr consiglia di esportare negli USA utilizzando ancora i codici UPC. I codici UPC sono richiedibili sempre tramite l’Indicod-Ecr.
In Europa è invece adottato il sistema EAN 13 (European Article Number), il che comporta che ad ogni prodotto venga attribuito: a) un codice di identificazione numerico composto da 13 cifre; b) una corrispondente rappresentazione grafica, ovvero un simbolo a barre verticali, destinato alla lettura ottica. L’identificativo della nazione è il primo numero indicato. Fanno eccezione, per le particolarità del mercato mondiale, il settore dei periodici, dei libri e della musica a stampa i cui codici EAN iniziano rispettivamente con 977, 978 e 979 in tutto il mondo.
Ormai desueto, di fronte a tante innovazioni, è il cd. LC (Label Code), codice rilasciato dal 1977 dalla già menzionata IFPI a ogni etichetta fonografica richiedente, cui veniva attribuito un numero progressivo (prima di quattro poi di cinque cifre) identificativo delle proprie produzioni (ad es. «LC 0542» designa la EMI Records) così da poter più facilmente distinguere il produttore avente diritto.
Per concludere questa carrellata, puramente illustrativa, segnaliamo che di recente sono stati introdotti due codici di interesse del settore musicale, sviluppati dalla DDEX (Digital Data Exchange) nell’ambito del progetto MI3P (Music Industry Integrated Identifiers Project).
Il primo è il codice MWLI (Musical Works Licence Identifier), dalle ampie prospettive, visto che consente di monitorare lo stato dei diritti d’autore in licenza, opera per opera. L’utente potrà conoscere, grazie al MWLI, se l’opera è o meno in regime di licenza, a chi è assegnata, per quanto tempo, ecc. Tuttavia lo sviluppo e la diffusione di questa codifica sono ancora agli albori, dovendo per forza di cose essere armonizzato e coordinato con molti dei codici visti in precedenza, come l’ISWC e l’ISRC. La gestione spetta alla IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), ovvero dall’associazione internazionale dei produttori fonografici.
Altro risultato delle ricerche MI3P è il GRid (Global Release Identifier), gestito dalla CISAC. Questo sistema risponde all’esigenza di monitorare, nell’ambito del commercio elettronica, le pubblicazioni di fonogrammi, videogrammi e altre risorse in formato digitale. L’obiettivo è quello di integrare i sistemi visti in precedenza, come l’ISRC.Nell’ultimo appuntamento abbiamo passato in rassegna i codici ISWC e ISRC, d’uso per «marchiare» fonogrammi e opere musicali e consentire una miglior gestione e distribuzione degli stessi. Nondimeno nel mondo della musica non mancano altri numerosi codici e relativi risvolti applicativi.
Abbiamo citato nell’articolo precedente i codici CAE/IPI (ovvero codice Compositeur, Auteur, Editeur e codice Interested Party Information), anticipandone la funzione: vengono associati dalla CISAC ai soggetti aventi diritto, rientranti nella propria banca dati perchè coinvolti nella gestione collettiva dei diritti su opere musicali. In Italia la SIAE li associa automaticamente ai propri iscritti. Il CAE era il codice in vigore in passato, creato nel 1992 dalla SUISA (la SIAE svizzera) e impiegato dalla CISAC per identificare i compositori, autori ed editori, poi sostituito dall’ottobre 2001 dall’IPI che identifica un raggio più ampio di soggetti, opere e diritti (vedi anche su http://www.ipisystem.org). Viene rilasciato esclusivamente agli iscritti alle società di collecting affiliate CISAC e può essere adoperato per ritrovare altre opere facenti capo allo stesso soggetto, favorendo la gestione amministrativa, le ricerche di opere e dei loro aventi diritto. Il motore di ricerca universale dei codici IPI è l’ISWCNet database, liberamente consultabile (vedi il sito http://iswcnet.cisac.org/ISWCNET-MWI).
Il codice IPI identifica il ruolo del soggetto, che può essere di: editore, compositore (delle musiche), autore (del testo), arrangiatore (di musiche), adattatore (di testi), ecc. Un esempio di codice IPI può essere il seguente: I-000000229-7, di cui è evidente la suddivisione in prefisso del soggetto e numero di posizione.
Il codice ISMN (International Standard Music Number) è invece un codice alfanumerico identificativo di musica stampata in pentagramma, sviluppato dalla Commissione Tecnica ISO/TC 46 – Informazione e documentazione, sottocomitato SC9, ed è diventato uno standard nel 1993 (riconosciuto come «ISO 10957»).
La sua funzione identificativa aiuta la gestione di pubblicazione, diffusione, vendita e prestito di musica a stampa. Va da sé che i soggetti maggiormente interessati sono gli editori di musica a stampa, i rivenditori della stessa e i bibliotecari. L’ISMN permette di identificare la musica scritta (a stampa o in digitale) distintamente dalle altre pubblicazioni (abbinate di solito al codice ISBN – International Standard Book Number) nella catena distributiva globale, permettendo di realizzare, con maggior razionalità «globalizzata», repertori commerciali e servizi specializzati per il mercato delle edizioni musicali. Le edizioni musicali, in vendita o a noleggio, disponibili gratuitamente, in regime di Creative Commons o secondo le ordinarie forme tutelate dalla legge, sono l’oggetto di codificazione ISMN.
Il codice è composto da 13 cifre suddivise in quattro porzioni, come per esempio: 979-0-2306-7118-7, dove: a) 979-0 è il prefisso che distingue l’ISMN dagli altri codici standard; b) 2306 è il codice editore, il quale identifica uno specifico editore di edizioni musicali; c) 7118 è il codice prodotto che identifica una specifica pubblicazione di edizioni musicali; d) 7 è la cifra di controllo. Come tale, il codice può anche convertirsi in un formato grafico di codice a barre.
Il codice è assegnabile a diversi formati del pentagramma: si possono marcare partiture d’ogni tipo, altri media che siano parte integrante di una pubblicazione musicale (come per es. il CD con le registrazioni se abbinato all’edizione a stampa), testi di canzoni pubblicate con la musica a stampa (se disponibili separatamente), commenti critici pubblicati con la musica a stampa (se disponibili separatamente), musica stampata in Braille e persino pubblicazioni in formato elettronico (pensiamo per es. a un pentagramma in versione .pdf).
Non è invece attribuibile l’ISMN a libri che vertono sulla musica (si deve adoperare il citato codice a barre per l’editoria, l’ISBN), a registrazioni musicali o video non strettamente abbinati a un’edizione a stampa (per cui vale un codice a barre per beni di consumo, come l’EAN 13), a periodici e a libretti d’opera (sempre soggetti al codice ISBN).
In Italia l’agente esclusivo responsabile è Informazioni Editoriali I.E. S.p.a. di Milano, (contattabile via e-mail a info@ismn.it), mentre informazioni generali sono disponibili sul sito http://www.ismn.it. Chi è interessato ai codici ISMN deve inoltrare un modulo di richiesta prestampato all’agenzia italiana, così da ottenere i propri identificativi (in particolare quello di editore). Il servizio ISMN ha un costo, variabile a seconda del numero di partiture da editare, oscillante tra i 40 euro e i 1.500 euro per gruppo di codici.
L’agenzia invierà all’editore richiedente le schede bibliografiche, complete di codice ISMN precalcolato, che l’editore dovrà compilare e rispedire all’agenzia ogni volta che attribuirà un codice ISMN a una sua pubblicazione. A richiesta, pagando un costo supplementare, l’agenzia potrà rilasciare un annesso codice a barre EAN, i cui dettagli vedremo oltre.
L’editore, o altro soggetto richiedente il codice, stamperà il codice sull’opera al momento della stampa (ed eventuale ristampa) o comunque della pubblicazione, con un carattere leggibile e non inferiore a determinate dimensioni. È importante segnalare che sebbene il codice ISMN sia univoco per ogni opera, in caso di pubblicazione di parti separate della stessa si dovrà provvedere all’assegnazione di uno specifico codice cadauna.
Nell’era del digitale (una causa dello sviluppo dei codici qui illustrati) non possiamo mancare di riferire del DOI (Digital Object Identifier – Identificatore di Oggetto Digitale), sorta di codice a barre per la dimensione digitale (pensiamo a tutti i sistemi di reti ed il Web, in particolare per il commercio elettronico). Lanciato dalla Association of American Publishers e dalla Corporation for National Research Initiatives nel 1997, il DOI si propone come un permanente e affidabile sistema di identificazione di oggetti digitali, basato sulla tecnologia CNRI Handle System® e su di un database dei dati identificativi degli oggetti, tale da permetterne un efficace reperimento. Virtualmente il DOI è applicabile a ogni tipo di opera dell’ingegno – in qualsiasi formato – quindi anche ai fonogrammi e videogrammi musicali, indipendentemente dal supporto ove siano stati originariamente fissati.
Lo sviluppo tecnologico è compito del CINECA (consorzio di Università italiane) mentre la coordinazione europea è a cura dell’AIE (Associazione Editori Italiani): proprio così, una volta tanto è l’Italia a guidare l’Europa! In particolare dal punto di vista della gestione della mEDRA (Multilingual European DOI Registration Agency), l’agenzia europea di registrazione dei DOI, competente per i servizi forniti ai registranti (assegnazione, accesso, ecc.). Tutte queste strutture lavorano, tra l’altro, per garantire la cooperazione del DOI con altri sistemi informativi e così fornire una maggiore utilità ed efficienza. Ricordiamo che l’ente di governo internazionale è l’IDF (International DOI Foundation), organizzazione no-profit istituita nel 1998 e che salvaguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale ad esso relativi.
Leggere un codice DOI non riserva, di per sé, grandi informazioni, essendo una semplice stringa (in formato ANSI/NISO Z39.84 – 2000) spartita in un prefisso («10.» seguito dal codice dell’organizzazione assegnante) e un suffisso (univoca stringa alfanumerica). Un esempio può essere questo: 10.1000/182.
La funzione del DOI è soprattutto quella di consentire a qualunque utente di raggiungere la collocazione dell’oggetto (soprattutto su Internet) e ottenere informazioni su di esso, visto che al contenuto vengono associati dei metadata di riferimento (bibliografico, commerciale, di collocazione nell’offerta editoriale), sempre aggiornabili. Sul Web è difatti possibile consultare la DOI Directory (vedi sul sito http://www.doi.org), mediante la quale è possibile, per autori, editori, distributori e utenti di contenuti digitali farsi conoscere, citare e ricercare, giovandosi all’uopo di un sistema persistente oltre che della gestione delle relazioni tra oggetti digitali e il deposito volontario di opere. Spieghiamoci meglio: identificando il contenuto dell’oggetto, invece dell’indirizzo URL nel Web dello stesso, il DOI consente di reperire risorse anche quando la pagina di collocazione sia mutata. Non solo: il DOI può costituire la prova che in una data precisa sia stata pubblicata una determinata opera. Con quale forza legale, è tutto da vedere a seconda del sistema legale del Paese ove si vuole ottenere la prova. Ad esempio, nel nostro Paese tale effetto è tutto da valutarsi e non è detto che possa essere di grande rilievo, essendo rimesso alla valutazione caso per caso del giudice. In futuro però un intervento legislativo, di taglio comunitario e poi nazionale, potrebbe rendere il valore legale del DOI assolutamente alla pari con altri già accreditati di pieno effetto, come la firma digitale, posto che viene rispettato il requisito della terzietà del certificatore. Le prospettive sono interessanti, vedremo.
Tutti conosciamo i classici codici a barre che quotidianamente ritroviamo su vari beni di consumo (nella classica forma di numeri e corrispondenti barrette verticali a contrasto), però anche questo tipo di codificazione conosce differenti standard, non da ultimo territoriali. La storia dei codici a barre comincia nel dopoguerra e trova solo negli anni ‘70, dapprima negli USA, lo sviluppo odierno. Nella musica il codice a barre è indicato per la stampa di supporti (fonogrammi o videogrammi, ove identificano l’intero prodotto e non le singole tracce) destinati alla commercializzazione, così da permettere ai distributori e rivenditori una razionale gestione dei flussi di magazzino e movimento merci, molto più rapidi grazie all’impiego dei lettori elettronici di codici a barre. Analogamente a codici già illustrati in precedenza, i codici a barre si dimostrano affidabili specialmente grazie alla cifra di controllo impiegata (cd. check digit) a fine codice.
Si noti che attualmente, in virtù di accordi internazionali tra varie agenzie come l’ISMN e l’ISBN, un editore che voglia apporre un codice a barre sui propri prodotti editoriali (e solo su questi, come ad es. un libro o uno spartito musicale) non è più obbligato a iscriversi a Indicod-Ecr per ottenere il codice a barre, bensì può fruire dei codici a barre in formato GTIN-13 forniti dalle altre agenzie, come appunto l’ISMN. Un esempio: il codice GTIN-13 per la musica a stampa è composto dal prefisso «979» seguito dal numero ISMN. Chiariamo che il GTIN-13 è solo una struttura numerica impiegata nei codici, non una tipologia di codice. È giunto ora il momento di introdurre i veri e propri codici a barre.
Parlando di codici a barre, la confusione di solito regna sovrana, vista la ricchezza di formati vecchi e nuovi ancora in vigore. Per fornire un primo orientamento possiamo dire che i due formati internazionali di base sono l’EAN e l’UPC, i quali però dal 2010 verranno affiancati a tutti gli effetti (specie sul fronte della compatibilità di lettura) da quello che dovrebbe essere il nuovo formato internazionale (già in uso), ovvero il GS1, che però non sostituirà del tutto i precedenti. Vediamone i dettagli per singoli codici, partendo dall’ultimo citato.
In Italia l’operatore della musica che desideri farsi rilasciare un codice a barre per un prodotto può richiederlo, nel formato GS1, all’Indicod-Ecr, l’istituto per le imprese di beni di consumo (vedi il sito http://www.indicod-ecr.it). Il rilascio è subordinato all’adesione ad Indicod-Ecr da parte dell’azienda produttrice/distributrice/importatrice del prodotto, azienda come tale responsabile di fronte ai consumatori nella veste del marchio apposto sulle confezioni. Cosa viene rilasciato esattamente? Viene attribuito un codice impresa di nove cifre, necessario prefisso per il codice completo (cui va aggiunto il prefisso territoriale italiano: «80-83»). Sarà poi il richiedente a generare da sé i relativi codici per prodotto (di tre cifre più una di controllo), mediante numerazione progressiva, tenuto conto che si potranno assegnare 1.000 codici articolo (da 000 a 999) e non di più, salvo l’assegnazione di un nuovo codice impresa. Si badi bene che il codice a barre identifica univocamente e universalmente un prodotto e il suo produttore, ma non contiene altri meta-data o informazioni, tranne casi particolari non applicabili al settore musicale.
L’iscrizione all’Indicod-Ecr avviene mediante compilazione di un form online, allegando la ricevuta di pagamento di una quota di iscrizione iniziale e di una fissa annuale. La quota di iscrizione varia a seconda di alcuni parametri, come il fatturato del richiedente. Iscriversi a Indicod-Ecr vuol dire far parte di un’associazione non a scopo di lucro, di cui si deve aver letto, compreso e condiviso lo Statuto.
Citiamo en passant che un «concorrente» internazionale del GS1 è il codice EPC (Electronic Product Code™), sorta di etichetta elettronica gestita internazionalmente dall’EPC Global (Indicod-Ecr in Italia). Le informazioni sul prodotto associabili e ricavabili da questo codice sono innumerevoli: qualsiasi caratteristica, il produttore e il prezzo sono alla base del codice. Le strutture numeriche utilizzate sono quelle tipiche del GS1 (come il citato GTIN) tuttavia il sistema di numerazione è estremamente versatile e potente, a 96 bit, e fornisce un unico numero identificativo a 268 milioni di aziende, ognuna delle quali avrà a disposizione 16 milioni di categorie e 68 miliardi di numeri seriali per ciascuna categoria di prodotto. Al codice in parola corrisponde l’EPCglobal Network, ovvero il database comune e a libero accesso, sviluppato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), sfrutta le componenti hardware e software per collegare i singoli server/database dei sottoscrittori/utenti, per garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e delle merci movimentate lungo la catena commerciale. Si evince, da quanto detto, che i vantaggi di questo standard, ancora in fase iniziale, sono innumerevoli e di certo lo sono l’incomparabile mole di informazioni codificata, la funzione anticontraffazione, la capacità di rilevamento attraverso sistemi a radio frequenza, la facilità di reperimento tramite Internet. Naturalmente una tale complessità richiede l’apposizione in un microchip, non bastando il canonico numero con rappresentazione grafica. Le prospettive dell’EPC sono molte alte, mirando ad una «connettività universale» tra tutti gli oggetti del mondo fisico.
Tornando ai codici oggi standardizzati, una particolarità riguarda il mercato nordamericano (Stati Uniti e Canada): lì infatti il formato del codice a barre è il cd. UPC (Universal Product Code), composto da solo 12 cifre, diversamente da quello europeo di 13. Sebbene teoricamente dal gennaio 2005 i rivenditori americani abbiano assunto l’impegno di far riconoscere i codici europei a 13 cifre ai propri scanner e apparecchi di lettura, di fatto Indicod-Ecr consiglia di esportare negli USA utilizzando ancora i codici UPC. I codici UPC sono richiedibili sempre tramite l’Indicod-Ecr.
In Europa è invece adottato il sistema EAN 13 (European Article Number), il che comporta che ad ogni prodotto venga attribuito: a) un codice di identificazione numerico composto da 13 cifre; b) una corrispondente rappresentazione grafica, ovvero un simbolo a barre verticali, destinato alla lettura ottica. L’identificativo della nazione è il primo numero indicato. Fanno eccezione, per le particolarità del mercato mondiale, il settore dei periodici, dei libri e della musica a stampa i cui codici EAN iniziano rispettivamente con 977, 978 e 979 in tutto il mondo.
Ormai desueto, di fronte a tante innovazioni, è il cd. LC (Label Code), codice rilasciato dal 1977 dalla già menzionata IFPI a ogni etichetta fonografica richiedente, cui veniva attribuito un numero progressivo (prima di quattro poi di cinque cifre) identificativo delle proprie produzioni (ad es. «LC 0542» designa la EMI Records) così da poter più facilmente distinguere il produttore avente diritto.
Per concludere questa carrellata, puramente illustrativa, segnaliamo che di recente sono stati introdotti due codici di interesse del settore musicale, sviluppati dalla DDEX (Digital Data Exchange) nell’ambito del progetto MI3P (Music Industry Integrated Identifiers Project).
Il primo è il codice MWLI (Musical Works Licence Identifier), dalle ampie prospettive, visto che consente di monitorare lo stato dei diritti d’autore in licenza, opera per opera. L’utente potrà conoscere, grazie al MWLI, se l’opera è o meno in regime di licenza, a chi è assegnata, per quanto tempo, ecc. Tuttavia lo sviluppo e la diffusione di questa codifica sono ancora agli albori, dovendo per forza di cose essere armonizzato e coordinato con molti dei codici visti in precedenza, come l’ISWC e l’ISRC. La gestione spetta alla IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), ovvero dall’associazione internazionale dei produttori fonografici.
Altro risultato delle ricerche MI3P è il GRid (Global Release Identifier), gestito dalla CISAC. Questo sistema risponde all’esigenza di monitorare, nell’ambito del commercio elettronica, le pubblicazioni di fonogrammi, videogrammi e altre risorse in formato digitale. L’obiettivo è quello di integrare i sistemi visti in precedenza, come l’ISRC.